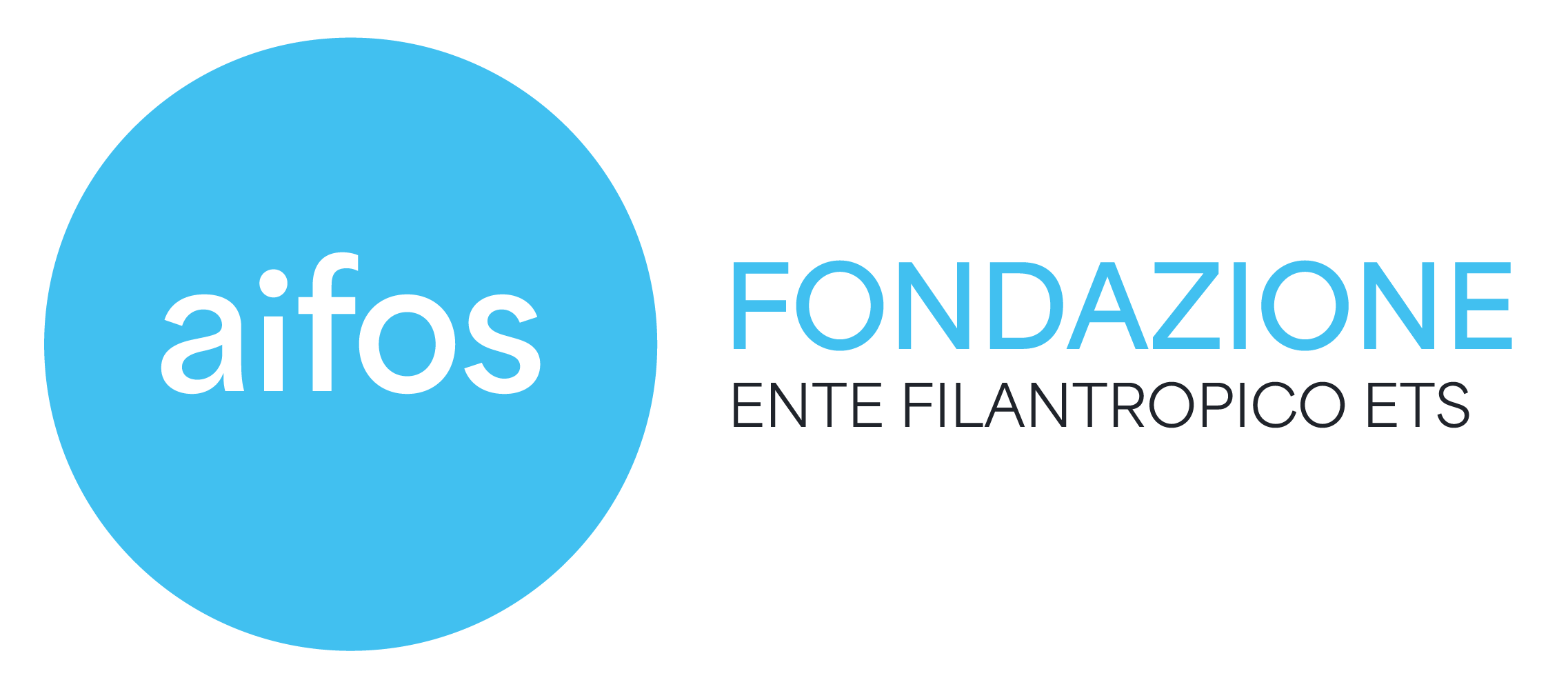/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti
Il lato oscuro degli appalti
Approfondimento per il Giornale dei Coordinatori di AiFOS a cura di Floriana Bulfon. Giornalista, scrive per "L'Espresso" e "La Repubblica”, è nota per le sue inchieste sulla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla città di Roma e a Mafia Capitale

 Gli appalti sono il modo in cui le istituzioni concretizzano la loro attività: un tempo erano solo le opere pubbliche, la dimostrazione della crescita dello Stato sul territorio. Adesso sono una massa crescente di servizi: se i bagni di una stazione sono puliti, se riusciamo a prenotare una visita medica, se l’autobus cittadino è in orario, dipende da come è stato gestita una gara d’appalto.
Gli appalti sono il modo in cui le istituzioni concretizzano la loro attività: un tempo erano solo le opere pubbliche, la dimostrazione della crescita dello Stato sul territorio. Adesso sono una massa crescente di servizi: se i bagni di una stazione sono puliti, se riusciamo a prenotare una visita medica, se l’autobus cittadino è in orario, dipende da come è stato gestita una gara d’appalto.
È dalla notte dei tempi che gli appalti sono il terreno privilegiato della corruzione. Se prendiamo il celebre processo a Verre con l'accusa condotta da Cicerone, ci rendiamo conto che la sostanza della malversazione prima ancora che nascesse Cristo era l’affidamento di servizi pubblici, dalla raccolta delle imposte ai lavori edili. Pochi pensano che sia possibile azzerare la corruzione: molti esperti, inclusi magistrati come Raffaele Cantone, sostengono che il vero problema non sia la corruzione in sé ma come renderla "sostenibile". Pure nel resto del mondo infatti girano tangenti. Ma nei Paesi cosiddetti occidentali poi le strade vengono comunque costruite a regola d'arte nei tempi previsti, mentre in Italia tutti conosciamo opere incompiute e strade più bucate della gruviera.
Questo è il primo problema. Da noi la corruzione è talmente invasiva da condizionare l'intero processo dell'appalto: dalla gara al cantiere, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Ciò dipende da un fattore chiave: la qualità della pubblica amministrazione, incapace di esercitare un controllo efficace sulle opere. Perché? I motivi sono diversi. Ad esempio, c’è chi sottolinea una scarsa qualità nella selezione del personale, nella formazione e nell’aggiornamento. C’è sicuramente un eccesso di norme e di procedure, complesse e confuse, tanto che l’ex ministro Giulio Tremonti ha parlato di “burocrazia criminogena”. Ma c’è un altro elemento: i quadri della pubblica amministrazione non hanno una reale autonomia e dipendono interamente dalla politica, che arbitra assunzioni e carriere. Quando Enrico Berlinguer denunciò la "questione morale" nella celebre intervista a Eugenio Scalfari non parlava di bustarelle ma della lottizzazione partitica di qualsiasi ente pubblico: quello da cui sono nate le basi della vecchia Tangentopoli. Come funzionava? I partiti si erano divisi amministrazioni a ogni livello - dai ministeri ai comuni - e pretendevano quote di finanziamento illecito ossia mazzette in base al loro peso politico. Ma è conseguenziale che se tutti i partiti avevano intascato qualcosa nessuno poteva poi contestare la lentezza o la bassa qualità dei lavori, che spesso venivano giustificate - in maniera ovviamente riservata - dalle imprese con la necessità di rientrare della spesa per le tangenti.
Quel sistema almeno aveva delle regole. Ma c'è un soggetto che vuole solo le “sue” regole: la mafia. Per le organizzazioni criminali italiane gli appalti sono la seconda sorgente di guadagni: solo il narcotraffico le arricchisce di più; il racket e gli altri affari illeciti rendono molto meno. Sapete qual è l’inizio della saga dei corleonesi? Nel primo dopoguerra si lanciano nel contrabbando di carne e comprano camion per spostare i vitelli; poi quando nel loro territorio viene costruita una diga, usano quei camion per fare il trasporto terra. Come ottengono questo subappalto? Perché l'impresa che realizza la diga viene minacciata e capisce che inserendo i corleonesi nel cantiere avrà anche una garanzia di sicurezza. Dagli anni Cinquanta in poi le mafie hanno gestito ditte sempre più grandi, con una crescita continua che dall’edilizia si è estesa in altri settori. In Sicilia e in Campania anche i colossi impegnati nella realizzazione di grandi opere – ad esempio l'Alta velocità Roma-Napoli o la terza corsia dell’Autosole - compravano il cemento dalle imprese dei clan e gli affidavano il movimento terra: persino la Calcestruzzi di Raul Gardini è venuta a patti con Cosa nostra.
Fino agli anni Novanta c'era "il tavolo a tre gambe": ogni appalto nel Sud, con l'eccezione di alcune zone della Puglia, era deciso da un accordo tra boss, politici e aziende. Ora le cose sono cambiate. Per due motivi. Anzitutto si è dissolta la struttura dei partiti, sempre meno organizzati. Alle correnti di una volta si sono sostituiti gruppi di potere, che passano da uno schieramento all’altro portandosi dietro il loro pacchetto di voti e di relazioni. Al livello più basso, quello dei Comuni ma talvolta pure nelle Regioni, questa metamorfosi coincide con il proliferare delle liste civiche o dei micropartiti di centro. In questa frammentazione dei partiti, spesso il politico è una figura che sin dall’esordio ha un legame con il clan e ne rappresenta gli interessi: quindi due delle gambe del “tavolo” vengono a fondersi. Succede pure però che il politico oltre che mafioso – o comunque legato strutturalmente a un clan – sia anche imprenditore: incarna contemporaneamente le tre gambe del “tavolo”. Questa metamorfosi si è vista negli atti di indagini a Roma: non ci sono più sistemi di corruzione geometrici ma “gelatinosi”, che avvinghiano in un coacervo di relazioni illecite tutte le procedure di gestione del denaro pubblico.
La criminalità organizzata poi ha grande dinamicità imprenditoriale: è sempre pronta a studiare nuove opportunità di profitto. Ha dalla sua la disponibilità di cash, frutto del traffico di droga, che permette di investire senza dipendere dagli istituti di credito. Inoltre, ha il controllo del territorio, con la possibilità di unire alla corruzione la minaccia della violenza e l’intreccio con la politica: riesce a ottenere autorizzazioni più rapidamente delle aziende oneste. Se un tempo si occupava solo di edilizia, cemento, movimento terra e rifiuti, adesso ha diversificato le sue attività: gestisce cooperative di servizi nelle pulizie, nelle mense, nella manutenzione delle strade e del verde. Se poi invece guardiamo ai campi di investimento privato, allora si nota l’espansione nel turismo, nella ristorazione, nell’agroalimentare e persino nel tessile, seppur finora confinato al mercato dei falsi. Alcuni analisti ritengono che il Covid e la pioggia di commesse legate al Pnnr stiano incentivando un altro salto di qualità della mafia imprenditrice – indicato ad esempio dalle analisi Cerved sui cambi di proprietà delle aziende – spingendola all’ingresso nell’impiantistica, nella produzione di energia, nella distribuzione di idrocarburi.
Il modello di business della Mafia Spa è semplice: sfruttare i propri punti di forza – la disponibilità di capitali, le relazioni con la pubblica amministrazione, la possibilità di usare la violenza contro i rivali – per diventare protagonista degli appalti o quantomeno dei subappalti del Pnrr. Ormai può contare sulla disponibilità di professionisti di ogni categoria che dalle Alpi al Canale di Sicilia non si fanno scrupoli nel lavorare con i clan. Ma soprattutto può trarre beneficio dalla diffusione di una “mentalità mafiosa” in fasce sempre più larghe dell’imprenditoria italiana, che imitano i metodi dei boss. Gli attentati del racket o le minacce denunciate nei cantieri sono ormai rari: i magistrati ripetono che i clan non sparano più. Non ne hanno bisogno: trovano con facilità chi è pronto a collaborare con loro. Ignorando che i padrini non accettano partnership: sono predatori che vogliono comandare. Se gli vengono aperte le porte di un’azienda o di un cantiere, il loro obiettivo sarà sempre quello di prenderne il controllo totale.
Contatti
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00
Tel. 030 6595031
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing