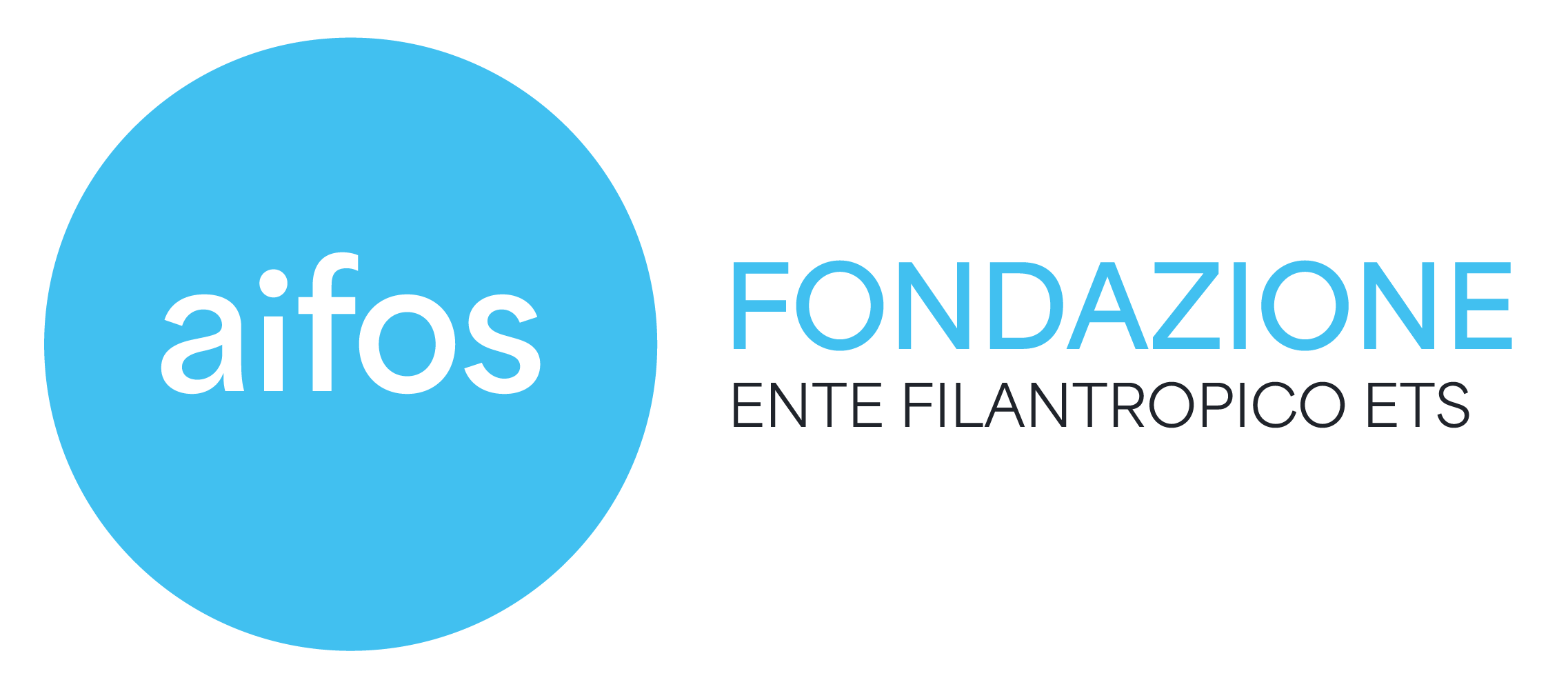/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti
La regola dell’arte
Un termine molto spinoso per tutti i professionisti del settore impiantistico, avvolto da una fitta nebbia interpretativa. Approfondimento a cura di Giovanni Villarosa, senior security manager con estensione al DM 269/2010, master STE-SDI in sistemi e tecnologie elettroniche per la sicurezza, difesa e intelligence

 Ho scritto questo contributo tecnico cercando di esplicitarlo il più possibile nel dettaglio, perché reputo l’argomento sulla certificazione della “regola dell’arte”, molto spinoso per tutti i professionisti del settore impiantistico, soprattutto dal lato della sicurezza “safety” degli impianti realizzati, ancor prima della loro corretta funzionalità.
Ho scritto questo contributo tecnico cercando di esplicitarlo il più possibile nel dettaglio, perché reputo l’argomento sulla certificazione della “regola dell’arte”, molto spinoso per tutti i professionisti del settore impiantistico, soprattutto dal lato della sicurezza “safety” degli impianti realizzati, ancor prima della loro corretta funzionalità.
Espressione spesso citata dai più, la cui conoscenza da parte dei professionisti (progettisti/installatori), risulta il più delle volte avvolta da una fitta nebbia interpretativa, spesso approcciata con differenti correnti di pensiero, quando non addirittura applicata in diversa maniera.
Il settore dell’impiantistica industriale elettrica, ed elettronica (security, safety, building automation), è dominato da una serie infinita di norme e disposizioni normative, sistematicamente disomogenee tra loro, quando non curiosamente in antitesi, in fatto di responsabilità civili/penali.
È per specializzazione affine al comparto industriale degli “impianti tecnologici”, nel loro insieme, dunque appare evidente come gli adempimenti normativi di settore siano fortemente comuni ad entrambi, seppur con talune sfumature, ma sempre nel perimetro vincolato delle norme CEI/UNI, del DM 37/08 e della Legge n° 186/68, tanto per citarne alcune.
Inoltre, ogni professionista che viene meno ai vincoli contrattuali, convenuti con la committenza, ne risponde sempre in sede civile del “danno contrattuale” cagionato dalla violazione. Oltre a ciò, può rispondere, nella stessa sede, anche del “danno extracontrattuale”, contemplato allorquando il professionista non è rispettoso della buona “regola dell’arte”, che si concretizza nel momento in cui non presta la dovuta “diligenza tecnica” propria delle sue capacità e cognizioni tecnico-normative.
Ciononostante, abbiamo però due casi nei quali il professionista non ne risponde, ovvero: quando nel contratto di commessa sarà espressamente prevista una certa discrezionalità tecnica gestita dallo stesso, che però dovrà sempre muoversi nell’alveo dell’obbligatorietà tecnica, mentre, in secondo luogo, quando la committenza imponga le sue esigenze, laddove poi il professionista renderà edotta la stessa sulla reale possibilità di una “risultanza tecnica imperfetta” dei lavori commissionati.
Sebbene la nozione regola dell’arte abbia registrato una vasta divulgazione e il suo concetto inserito nei contratti, come nelle sentenze, pur essendo espressamente citata nell’art. 2224 del Codice Civile (C.C.) dove è scritto che “il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”, ebbene, nonostante ciò mai è stata fornita una esplicazione tangibile della “regola”.
Invero, è proprio nel settore impiantistico elettrico che rinveniamo una prima definizione della suddetta regola, infatti, all’interno dei due e unici articoli della Legge n° 186/1968 sulle “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”, così è scritto:
art. 1, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte;
art. 2, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte.
Del resto, è lo stesso significato rinvenuto in un’altra Legge, la n° 46/1990 sulle “Norme per la sicurezza degli impianti”, sostituita poi nel prosieguo del tempo dal Decreto Ministeriale DM n° 37/2008 sul “Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, attività regolatoria che interesserà ancor di più i professionisti del settore, giacché nell’art. 6 è scritto:
“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.
Una disciplina applicativa, questa, basilare perché a caratterizzazione speciale per gli impianti elettrici (residenziali/industriali) ed elettronici (security/safety), puntuale negli aspetti progettuali, procedurale e documentali, precisa nel dettato installativo degli impianti tecnologici.
Concetti questi, ulteriormente rimarcati quando si realizzano installazioni, elettriche o elettroniche che fossero, negli ambienti di lavoro là dove impera il D.Lgs n° 81/2008, meglio conosciuto come il “Testo Unico” sulla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dove nell’art. 81 riafferma parimenti il concetto:
comma 1. tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte;
comma 2. ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche;
Pur tuttavia, quando le norme tecniche (CEI/UNI, etc) non trovano applicazione, ebbene, una risposta alla definizione della regola dell’arte la dobbiamo pur trovare!
Sul punto rinveniamo una possibile soluzione nella locuzione legislativa “Bonus pater familias”, ovvero, l’attenzione del “buon padre di famiglia”, che si concretizza giuridicamente con l’agire con perizia, prudenza e diligenza, secondo quanto contenuto nell’art. 1176 C.C.; indubbiamente, ciò posto rappresenta la diligenza media che si deve presuppone nell’uomo medio, ovverosia, la valutazione di “quella diligenza” che il codice sollecita affinché non sussista una colpa.
Pertanto, in questa fattispecie, sarà più laborioso e particolarmente macchinoso poter dimostrare come si applichi concretamente la regola d’arte, non avendo più nessun riferimento positivo e vincolante, proposto, ad esempio, dalla normativa tecnico-giuridica.
Orbene, alla luce di quanto accennato sin qui appare chiaro il fatto di non poter certificare, questa “astratta regola”, né come realizzarla in una maniera certa, tale da non prestarsi a svariate ed equivoche interpretazioni.
È tuttavia indubbio, alla stregua di quanto detto, come nel settore elettrotecnico si imponga, per progettare prima e realizzare poi impianti tecnologici “a regola”, il rispetto delle regolamentazioni (leggi e norme) che sono articolate in due tipologie di riferimento: la norma tecnica e la norma giuridica.
Peraltro, la conoscenza delle normative, nella esatta distinzione dottrinale tra norma giuridica e norma tecnica, rappresenta il presupposto fondamentale e imprescindibile per un approccio professionale alle problematiche tipiche del settore impiantistico elettrico ed elettronico; sistemi che andranno realizzati al solo scopo di conseguire quel “livello di sicurezza accettabile” che la norma impone, ma che non è mai assoluto, perché al progredire tecnologico seguirà sempre una consequenziale rideterminazione regolatoria fatta sia dall’ente normativo (CEI/UNI, etc), che dal legislatore (Leggi, DPR, DM, D.Lgs, etc).
E allora diamolo uno sguardo, seppur sommario, alla differenza che intercorre tra la norma tecnica e quella squisitamente giuridica.
Per definizione le norme giuridiche appartengono alla “famiglia” delle norme di diritto, che impongono, in uno specifico settore, “regole” di condotta da seguire e quelle da evitare, mentre le Leggi (scomponibili anche in più norme specifiche) hanno una caratterizzazione di applicabilità di larga portata.
D’altra parte, sebbene queste terminologie siano spesso assunte come sinonimi, la norma non va mai erroneamente confusa con la Legge, perché anche avendo sì le stesse caratteristiche (imperatività, positività, etc), si sostanziano, e dunque si differenziano, per la portata: la norma possiede un valore limitato in uno specifico settore, al contrario della Legge che assume un valore di rilevanza generale, su regole di vita, di condotta e di comportamento.
Diversamente, l’osservanza delle norme tecniche non è obbligatoria per volontà espressa dal legislatore, che non le connota come Leggi, ma le considera piuttosto come “documenti” che definiscono talune prassi, caratteristiche, processi, secondo uno “stato dell’arte” tecnologico del momento, dichiarandone pertanto la volontarietà di queste fonti.
Quindi, a ben vedere, non rappresentano l’esercizio in capo al potere legislativo, in quanto rappresentano il prodotto dell’elaborazione e dell’aggiornamento continuo che gli enti di normazione, in base allo sviluppo tecnico scientifico, pongono in essere in delegazione di tutte le parti socioeconomiche interessate.
Questo è sempre vero laddove le norme volontarie sono considerate “isolatamente”; diversamente, non è mai vero quando le norme tecniche e giuridiche si condizionano a vicenda, esercitando un impatto “giuridico” le une sulle altre, nella fattispecie applicativa propria dei loro ambiti di appartenenza, meglio conosciuta come “sfera di influenza”.
Un effetto di tal genere diventa cogente nel momento in cui la norma tecnica è richiamata all’interno di una Legge, e dunque, questo richiamo fa valere il principio giuridico per cui qualsiasi norma richiamata assume la forza di Legge.
È ben vero allora, e ora lo sappiamo con certezza, che solo quando il professionista applicherà con diligenza tali “indirizzi” dimostrerà un metodo deontologicamente corretto nel soddisfare il dettato applicativo della Legge 186, garantendo peraltro, quel “livello minimo di sicurezza” rispondente proprio alla regola dell’arte, e dunque, applicando la normativa tecnica di riferimento non è più tenuto a dimostrare di avere lavorato secondo i vincoli della Legge.
Detto ciò, appare evidente come la regola dell’arte vada considerata quale elemento in continua evoluzione dottrinale, ma riferita sempre allo “stato dell’arte” tecnologico in cui si opera, alla conoscenza tecnica del periodo, della normazione e delle vigenti leggi.
Quanto appena sostenuto sottolinea con forza l’obbligo per il professionista nel mantenersi sempre aggiornato sulla evoluzione tecnico-normativa (CEI, EN, UNI, etc), e su quella legislativa (Leggi, DPR, DM, DLgs, etc.), perché il mancato rispetto delle “Norme”, a prescindere dall’osservazione o meno dei singoli vincoli contrattuali, determinerà sempre una giudiziale responsabilità per danni, confermata peraltro dalle molteplici pronunce giurisprudenziali (civili/penali), tanto di merito (Tribunali, Corti d’Appello) quanto di legittimità (Suprema Corte di Cassazione).
Né può, del resto, essere mai sottovalutata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del professionista che opera nel settore della sicurezza, dato che la tal cosa nasce per effetto dell’entrata in vigore di indirizzi specifici contenuti nell’allegato K, appendice contenuta all’interno della norma CEI 79/3:2012, oltre all’azione delle sentenze di condanna nel risarcire danni per negligenza, colpa, errata progettazione/realizzazione, mancato o cattivo funzionamento dei sistemi di sicurezza in occasione di eventi criminosi.
A tale riguardo, ogni professionista è tenuto a mantenere sempre un comportamento diligente necessario alla realizzazione dell’opera, adottando puntualmente tutte quelle misure e cautele necessarie, idonee per la corretta esecuzione della prestazione commessagli, secondo un modello di accuratezza e di abilità tecnica.
Ora, la diligenza si evidenzia nei profili della cura, della cautela, della perizia, della legalità sotto l’aspetto dell’integrità materiale, come nella mancanza di vizi.
Mentre, la perizia si sostanzia, invece, nell’uso delle abilità supportate da appropriate nozioni tecniche caratterizzanti la professione svolta, anche mediante l’utilizzo della strumentazione adeguata e necessaria all’attività professionale.
Solo per citare qualche esempio, richiamiamo l’attenzione del professionista su alcune sentenze della Cassazione, come la sentenza n° 12879/2012, dove è scritto che se un sistema di sicurezza antirapina non funziona correttamente per difetti imputabili alla manutenzione, allorquando il sito protetto è soggetto ad evento rapina, l’azienda incaricata dell’appalto manutentivo né rispondere in solido dei danni sofferti, visto che:
“… se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo (sicché la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all’art. 115, secondo comma, c.p.c.)…”
In un’altra sentenza, la n° 12995/2006, si ribadisce ad esempio come il professionista, anche laddove si attenga rigidamente alle indicazioni del progettista, può essere chiamato alla corresponsabilità per i “vizi dell’opera” in quanto, conservando in ogni caso una sua autonomia, non esegue gli impianti secondo la regola dell’arte, o in assenza di specifica normazione; quindi, quando il danno è provocato da elementi non contemplati nei precetti dottrinali, andrà sicuramente esercitato il comportamento del Buon padre di famiglia (perizia, prudenza e diligenza) che l’installatore deve sempre osservare, quando la norma è carente.
Tuttavia, anche quando l’installatore, nei limiti e in base alle cognizioni tecniche da lui conosciute, non segnala al committente le carenze progettuali o gli errori macroscopici dell’opera da realizzare, sarà comunque ritenuto corresponsabile in caso di danno, anche quando abbia eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni in esso contenute, nonostante la presa di coscienza degli errori rilevati.
Diversamente, se il professionista rende edotta la committenza, documentando compiutamente i rilievi sulle eventuali carenze e/o errori progettuali, ma quest’ultima gli ordina comunque di eseguire le indicazioni palesemente errate del progettista, lo stesso sarà esente da ogni responsabilità, perché privato oggettivamente dalla libertà decisionale quale “nudus minister”, perché indotto comunque ad eseguirle su insistenza del committente, e a totale rischio di quest’ultimo (Cassazione sentenza n° 538/2012).
Partendo da questi capisaldi la Suprema Corte si è spinta oltre, stabilendo un assunto, secondo il quale, anche in assenza “specifica normazione tecnica” che obblighi precisi adempimenti, è configurabile la responsabilità per danni extracontrattuali conseguenti alla mancata osservanza delle generiche norme di salvaguardia.
D’altra parte, nel caso dell’installatore, tale figura opera spesso in un contesto eterogeneo, dove regolarmente vengono coinvolti più professionisti, e dunque, costretto a confrontarsi con progettisti, direttore dei lavori, responsabili della sicurezza, un fattore questo che implica possibili e significativi “effetti” in termini di responsabilità legali di “terzi” verso la committenza, però ascrivibili indirettamente anche allo specialista estraneo ai fatti.
Un classico esempio, che racchiude il tutto, è ben rappresentato da installazioni realizzate in zone classificate, e dunque altamente pericolose; ebbene, il mercato offre soluzioni di protezione per ambienti classificati di tipo “Ex d” ed “Ex tb” che consentono l’impiego, altrimenti impossibile, di strumentazioni e/o tecnologie non progettate per aree pericolose o a rischio di esplosioni.
In questo caso di “scuola” osserviamo diverse figure professionali coinvolte, ma con responsabilità interdipendenti tra loro:
- il produttore;
- il progettista;
- l’installatore;
Il produttore garantisce l’adeguato livello di sicurezza delle apparecchiature e ne certifica l’idoneità all’installazione nel corretto ambito operativo, vincolato a fornire specifiche tecniche chiare ed esaustive, su impiego, utilizzo, installazione e manutenzione.
Viceversa, il progettista è il responsabile del dimensionamento e della corretta selezione dei componenti certificati, sempre vincolata alle esigenze impiantistiche, operative e di utilizzo, nel pieno rispetto della conformità alle norme e ai limiti delle attestazioni funzionali dei componenti.
Invece, la responsabilità dell’installatore assume una posizione decisamente più ambigua, perché nel momento che riceverà la documentazione progettuale, ricadranno più incombenze su di lui, che sono quelle di attenersi alle indicazioni dettate dal progetto, verificandone però la fattibilità, come il rispetto dei limiti di utilizzo e installazione delle apparecchiature imposti dal produttore, e mai sindacabili, che non gli permettono modifiche di nessuna natura, anche quando effettuate alla regola d’arte, considerando che ogni modifica arbitraria annullerà la sicurezza funzionale, pregiudicandone, peraltro, la conformità alle norme di riferimento e, quindi, la validità stessa del certificato, vanificando nel suo complesso l’intera realizzazione.
Proprio su tali motivazioni la magistratura prenderà le necessarie contromisure processuali, affidando sempre più tutte le “indagini tecniche”, che riguardassero violazioni nel settore degli impianti tecnologici, con specifici incarichi investigativi volti a verificare la sussistenza giuridica di quell’accorgimento (bonus pater familias) che, quando non diversamente normato, avrebbe potuto evitare il concretizzarsi del danno e/o di un possibile reato, che si realizza in concreto con quanto già raccontato nella parte iniziale del nostro ragionamento, ossia: Perizia, Prudenza e Diligenza!
Ma la responsabilità dei professionisti del settore non si esaurisce esclusivamente nel solo ambito civile, perché per talune fattispecie viene estesa anche in quello penale, che ricordiamo, nell’ordinamento italiano è tipicamente “personale”.
Al riguardo è bene tenere a mente il disposto dei due commi dell’art. 40 del Codice Penale (C.P.) che dice:
- c1, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione;
- c2, non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Altri punti chiave del Codice sono l’art. 5 ignoranza della legge penale (leggasi conoscere le leggi della propria professione), l’art. 449, incendio colposo (leggasi l’errato dimensionamento di un impianto, la sua cattiva realizzazione, l’utilizzo non conforme di materiale e tecnologie), l’art. 451 omissione colposa di cautele/difese (leggasi per colpa, omissione, ovvero rimuovere, modificare o rendere inservibili apparecchi destinati alla sicurezza), l’art. 483, attestazione di falso in atto pubblico (leggasi falsa dichiarazione di conformità).
Quindi, da questa summa lettura emerge chiaro come in tutti i campi professionali è l’omissione colposa ad essere punita, e dunque, è certamente sulla base di questo elemento principe, ad esempio, che si possono ascrivere ai professionisti fattispecie penali per reati consumati nell’esercizio della propria attività, quando questa ne comporta l’assunzione di una “posizione di garanzia” (Cassazione sentenza n° 38624/2019), quale ad esempio quelle del progettista o dell’installatore di impianti tecnologici, quando quest’ultimi sono sottoposti a certificazione di legge.
In aggiunta a quanto scritto qualche riga più sopra, per concretizzare la condizione di una qualsiasi responsabilità penale del professionista, non occorre necessariamente l’accadimento reale dell’evento, perché in ambito penale sussistono anche i reati di “mero pericolo”, una fattispecie penale dove viene punito già il semplice insorgere del possibile pericolo per l’incolumità pubblica.
Riassumendo, dunque, possiamo affermare che:
- la regola dell’arte va intesa come quel complesso di regole tecniche da rispettare per garantire la realizzazione di opere con un livello minimo di accettabilità, in termini di gestione, efficienza, sostenibilità, durata e sicurezza del sistema reso;
- un professionista, in buona sostanza, per poter operare conformemente secondo tale regola deve anzitutto conoscere e applicare le relative norme tecniche di settore supportate dalla normativa giuridica di salvaguardia;
- sul punto, solamente gli impianti realizzati in conformità alle normative CEI/EN, sono, per la nostra legislazione, considerati realizzati alla regola dell’arte;
- ricevendo un progetto, il professionista dovrà essere sempre all’altezza di interpretarlo correttamente, come, peraltro, capace di stabilirne le carenze e le non rispondenze, compatibilmente alle conoscenze e capacità tecniche limitate al suo profilo professionale;
- al termine dei lavori dovrà sempre effettuare tutte le prove funzionali e le verifiche di sicurezza, certificando il tutto in accountability agli obblighi normativi.
Dunque, appare evidente che assecondare erroneamente il committente danneggerà inevitabilmente la credibilità del professionista, poiché le non conformità rappresentano una chiara responsabilità amministrativa, civile e penale, sulla quale poi la committenza potrebbe rivalersi in ultimo, anzitutto per discolparsi di fronte all’Autorità.
Dichiarazione di Conformità
Abbiamo analizzato fin qui come il primo riferimento assoluto di Legge, che dà forza giuridica alle Norme CEI, sia stata la Legge n° 186/1968; poi negli anni successivi, a seguito di vari recepimenti di Direttive europee, si ha un ulteriore riconoscimento giuridico della normativa tecnica, con il riferimento dato dalla Legge n° 46/1990 che introduce diverse novità, tra cui, l’obbligo di rispondenza alla Legge 186, gli ambiti di applicazione, i soggetti abilitati, i requisiti professionali, la certificazione di conformità per gli impianti realizzati, in ogni settore.
Legge poi ulteriormente modificata dal Decreto ministeriale n° 37/2008 (D.M.), sul “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, un provvedimento fondato sulle basi normative riprese dalla 46/90 e ampliate nello stesso, quale naturale evoluzione giuridica della Legge 46, ma con l’obiettivo di riordinare tutte le disposizioni relative all’installazione degli impianti tecnologici all’interno degli edifici, introducendo alcune importanti differenzazioni, quali, ad esempio, i requisiti per la progettazione degli impianti, che a differenza della vecchia 46/90 vengono normati in maniera più specifica, precisando meglio le peculiari competenze tecniche richieste ai professionisti installatori.
Uno dei punti salienti del Decreto è rappresentato certamente dall’art. 7 che introduce una novità certificativa, oltre alla già prevista Di.Co. della legge 46, denominata “Dichiarazione di Rispondenza” Di.Ri, quale ulteriore strumento certificativo utilizzabile solamente in via esclusiva.
A tal riguardo, mentre la Di.Co è obbligatoria per i nuovi impianti, la Di.Ri è essenzialmente un controllo che attesta, o nega, la corrispondenza dell’impianto ai requisiti normativi; parliamo dunque di una procedura straordinaria, che si deve applicare solamente ai così detti impianti “orfani” della certificazione Di.Co. non più reperibile, ma realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37.
Ora, proprio sulla scorta di quanto detto, ricordiamo ai professionisti “sbadati”, che la “Dichiarazione di Conformità” rappresenta un documento certificativo, ovverosia, una reale asseverazione, e dunque, un’attestazione pubblica con valore giuridico.
Pertanto, il distratto installatore che, ad esempio, rilascia la Di.Co. prima di aver terminato l’impianto, o assicura la regola dell’arte ad un impianto che non lo sia realmente, ebbene, dichiara pubblicamente il falso, e su tali elementi oggettivi può risponderne ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale (C.P.) sulla “Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità”, come anche dell’art. 483 C.P. sulla “Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”.
Per chiarire meglio questi concetti, ebbene, sarà di utile lettura lo stralcio di una sentenza emessa dal Tribunale di Savona nel novembre 1998, dove viene contestato, ad un professionista, proprio la fattispecie di reato di cui agli artt. 81, 481 e 61 C.P., …”perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere i reati di cui ai capi 2 e 3, quale soggetto abilitato ai sensi dell’art. 2 della legge n° 46/1990 alla installazione di impianti ed al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità, aveva falsamente attestato:
"a) che la data nella quale aveva verificato (collaudo) e certificato che gli impianti degli appartamenti degli immobili siti in ...omissis… fossero conformi alla regola dell’arte, era il giugno ed il luglio 1993, predisponendo a tal fine le dichiarazioni di conformità datate 10-6-1993 per l'immobile …omissis… e 6-7-1993 per l’immobile …omissis… , mentre tali controlli (collaudo) di conformità venivano in realtà svolti solo successivamente e precisamente nel corso del 1994…
b) che gli impianti degli appartamenti predetti erano conformi alla “regola dell’arte."
Ciò posto, premesso che l’art. 9 della legge n. 46/1990 obbliga l’impresa installatrice ad emettere solo al termine dei lavori la c.d. "dichiarazione di conformità", le acquisizioni dibattimentali hanno evidenziato la falsità delle date relative alle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’odierno imputato con riferimento agli impianti ubicati nel …omissis… “
Pur tuttavia, anche riconoscendo la regola dell’arte, da parte del collegio giudicante, il giudice ha confermato che rilasciare la dichiarazione di conformità anzitempo e senza aver concluso la realizzazione delle opere, costituisce di fatto la consumazione del reato della falsa dichiarazione nell’atto pubblico!
Non sfugge ai più, quindi, come l’installatore professionista rilasciando una falsa dichiarazione consuma un atto di rilevanza penale, un reato ascrivibile al soggetto previsto nell’art. 481 C.P., ovverosia “la falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità”.
Orbene, la definizione su cosa debba intendersi per servizio di pubblica necessità esercitato dal professionista la rinveniamo nell’art. 359 C.P.
Sul punto, inoltre, giova osservare come l’oggetto materiale del reato di falsità ideologica sia rappresentato da tutti quei documenti che la giurisprudenza ha puntualmente definito “quasi pubblici”, quale chiarimento della particolare tutela riconosciuta a questi atti, trattandosi di documentazione rilasciata da privati che esercitano professioni specializzate, sulle quali è richiesta una particolare abilitazione da parte dello Stato, ovvero, se della loro prestazione professionale il pubblico ne è vincolato dalla Legge a valersene.
Appare chiaro, pertanto, come la funzione certificativa attribuita ad un privato costituisca un servizio di pubblica necessità ex lege, trattandosi, infatti, di un esercizio di natura privata svolto dal privato installatore, ma che deve possedere però tutti quei requisiti tecnico-professionali vincolati alla norma di Legge.
Peraltro, il contenuto dell’ art. 8 del D.M., stabilisce che “il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate”.
Ma, oltre a ciò, la Di.Co ha un’ulteriore funzione, quella di garantire “a terzi” che i lavori siano stati realizzati secondo la regola d’arte, ma soprattutto che i materiali utilizzati siano rispondenti alla vincolante “regola”, per non dover rispondere anche del reato previsto all’art. 515 C.P., sulla “Frode nell’esercizio del commercio”, fattispecie configurabile quando la falsità della dichiarazione questa volta è relativa ai materiali utilizzati.
La dimostrazione verso terzi, ricordiamolo, è in ossequio al contenuto dell’art. 9 del D.M., quando si parla dell’attestazione di agibilità, dove: “il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti”.
Un principio previsto espressamente nel decreto, che, come abbiamo visto, obbliga poi gli organi della P.A. a poter rilasciare l’atto di idoneità alla “abitabilità/agibilità” solamente quando acquisirà la Di.Co, contestualmente al certificato di collaudo degli impianti installati, laddove previsto.
Ma il professionista è sempre obbligato al rilascio dell’atto di certificazione?
In circostanze del tutto eccezionali non è sempre obbligato al rilascio della dichiarazione di conformità, e sul momento non commette nessun illecito previsto all’art. 7 del D.M., perché sul punto è stata proprio la giurisprudenza a dissipare questo dubbio; infatti, nel caso in cui il committente si rifiuta, senza motivata ragione, di onorare il pattuito, allora l’impresa può legittimamente rifiutarsi di rilasciargli la dichiarazione di conformità.
Un principio questo, affermato in una sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Lodi nell’agosto 2016, che così scriveva: …“l’appaltatore ha portato a completamento l’opera materiale commissionatagli ed appare pertanto giustificato il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, tenuto conto del previo e più grave inadempimento imputabile al committente”…
Un pronunciamento emesso seguendo il solco tracciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8906/2013: …”se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l’appaltatore può legittimamente rifiutare di consegnargli la restante parte dell’opera” …
Concludiamo, sintetizzando:
- la dichiarazione di conformità “Di.Co” è una documentazione obbligatoria rilasciata da un professionista abilitato, dopo l’installazione o la manutenzione degli impianti;
- va rilasciata esclusivamente solo dopo aver eseguito tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto;
- dal momento del rilascio dell’atto il professionista si assume la responsabilità, civile nel caso di danno a cose e sotto il profilo penale nei casi di falsa attestazione degli atti e di danno alle persone, dell’impianto realizzato (art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità, art. 434 Disastro colposo, art. 449 Incendio colposo, art. 451 Omissione colposa di cautele/difese, art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, art. 515 Frode nell’esercizio del commercio, art. 589 Omicidio colposo, art. 590 Lesioni colpose);
- il professionista descrive la realizzazione e le tecniche installative, garantendone la regola d’arte e la conformità a tutti gli obblighi di legge.
Ciò posto, in linea generale l’impresa non può mai rifiutarsi di consegnare le dichiarazioni di conformità; ma detto rifiuto, però, potrebbe rivelarsi legittimo solo nel caso in cui il cliente, senza un motivo legittimo, ometta di pagare il corrispettivo all’impresa.
Contatti
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00
Tel. 030 6595031
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing